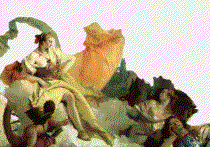
Qualcuna è un po’ scontata, ma proviamo ugualmente.
-Maestro, come ha cominciato? Tra il brusio della folla stupita ci pare di cogliere il nome di Gregorio Lazzarini, sì uno degli artisti più affermati del tempo a Venezia, ma anche dei “tenebrosi”, Bencovich e l’essenziale Piazzatta, dal quale derivano i dipinti scuri e fortemente contrastati della produzione giovanile. Però il vero riferimento è stato Paolo Veronese, la sua pittura timbrica, nella quale colori diversi si scontrano in una vibrazione luminosa dinamica.
A lui lo lega il filo, che non si è mai spezzato, del forte cromatismo veneto, splendente come i mosaici di S.Marco, e della composizione ardita e scorciata, popolata di esseri umani in costante dialogo fra loro. -Maestro, quali sono i punti fondamentali del suo linguaggio? Apelle-Gian Battista gira intorno il suo sguardo e lo posa su Cecilia; pare si siano amati teneramente, malgrado la sfilata di donne provocanti, forse deviazioni sentimentali esclusivamente artistiche. La sua risposta è implicita nella mostra, basta osservare un affresco, una tela. E’ la luce, una luce che irradia uno spazio illimitato, luogo di esplosione dell’immaginazione smisurata. Ma anche, come ebbe a dire Anton Maria Zanetti il Giovane, la conoscenza e l’applicazione della “grand’arte de’ contrapposti”.
-Maestro, ci illumini sul suo credo estetico. Ora la sua voce ci giunge più chiara e ferma, anche se egli ha già sessantasei anni e sta per partire per Madrid, chiamato da Carlo III di Spagna. “Li pittori devono procurare di riuscire nelle opere grandi, cioè in quelle che possono piacere alli Signori nobili, e Ricchi, perché questi fanno la fortuna de’ Professori, e non già l’altra gente, la quale non può comprare Quadri di molto valore. Quindi è che la mente del Pittore deve sempre tendere al Sublime, all’Eroico, alla Perfezione”. E noi, esemplari di una razza destinata all’estinzione per aridità di idee, usciamo da Cà Rezzonico con un misto di gioia esplosiva per l'Allegoria nuziale e di tristezza per la Deposizione nel sepolcro; così tragicamente “ultima” e immodificabile realtà, ma consapevoli di essere stati testimoni del passaggio di un genio.
La mostra di Ca' Rezzonico
La mostra di Würzburg
Itinerari veneziani
Tiepolo
a Udine
Tiepolo a Vicenza
Altri siti